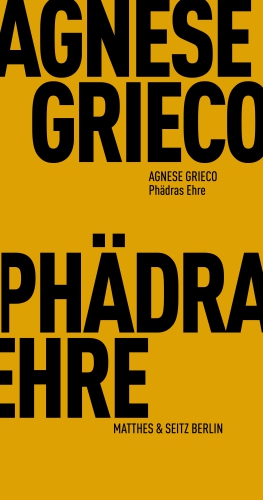Afrodite fa il suo ingresso in un interno polveroso, che sembra un vecchio ufficio della DDR: pareti rivestite di legno scuro, due sedie foderate, una poltrona, un tavolo; sul tavolo dei libri, un bicchiere, un posacenere e un pacchetto di sigarette.
La dea si siede e si mette a scorrere un copione, quello della vita di Fedra, che sembra già scritto dall’inizio. Annuncia al pubblico il destino in cui la donna si trova invischiata per volontà divina, che tutti già conoscono dall’Ippolito portatore di corona di Euripide: la follia d’amore per il figliastro Ippolito, tutto preso dalla caccia e dalla devozione per Artemide, di cui la dea è gelosa e intende vendicarsi. Ancora una volta la vicenda di Fedra sembra pronta a ripetersi identica, come avviene dal 428 a.C. Eppure, Fedra non è mai stata uguale a sé stessa e anche questa sera davvero poco si può dare per scontato di ciò che credevamo di sapere sulla meno eroica delle figure femminili del teatro greco. A Fedra mancano il coraggio di Antigone o la sventurata sorte di Cassandra; perché, dunque, una figura così poco esemplare continua ad attirare su di sé l’attenzione e a generare riscritture e nuove interpretazioni? E dove sta, nonostante tutto, la sua grandezza?
Lo spettacolo scritto e diretto da Agnese Grieco, Phädras Ehre, L'onore di Fedra - da Euripide, Seneca e Ovidio in scena il 23 ottobre, il 20 novembre e il 29 marzo 2026 , ritorna sull’enigma insoluto di Fedra, con una radicalità inedita, che libera la sua figura da pregiudizi e facili riduzioni a un femminismo di maniera, esplorando il lato oscuro del desiderio. Agnese Grieco, che è anche autrice di un saggio filosofico con lo stesso titolo dello spettacolo, va al cuore dei problemi posti dalla tragedia euripidea, dalle complesse dinamiche di genere alle oscillazioni di Fedra tra desiderio e norme sociali, mettendo al centro la donna innamorata e ciò che è disposta a fare in nome del demone che la abita. L’autrice ingaggia così una partita a scacchi con il razionalismo socratico, che predica l’impossibilità di praticare il male da parte di chi è cosciente del bene, offrendo una lettura dirompente del potere di cui una donna che desidera scopre d’un tratto di disporre.

Agnese Grieco ricostruisce così una figura prismatica in tutte le sue sfaccettature: se Euripide rimane la base di partenza e l’ispirazione primaria, la pièce integra anche passaggi tratti dalla cupa Fedra di Seneca e dalle Eroidi di Ovidio; nel testo e nella messinscena vibra la stratificazione delle riletture moderne del mito, specialmente quelle più oscure e fortemente provocatorie, da Swinburne a Sarah Kane, ma Grieco non intende tanto rappresentare il desiderio di Fedra, liberato da remore e tabù, quanto sondarne le conseguenze. Inoltre, Fedra diventa nelle sue mani il punto di Archimede da cui guardare, con occhio critico, alla trappola dell’identità, sia essa sociale, di genere, o quella che deriva dalla cristallizzazione dell’immagine di un personaggio femminile nella cultura collettiva.
La straordinaria interpretazione dell’attrice Sophie Rois, che assume i ruoli di Afrodite, Fedra e la nutrice, restituisce con la sua varietà di registri espressivi l’identità cangiante e precaria di Fedra, la raisonneuse, che già in Euripide si distingue per l’uso esperto della ragione, come un filosofo della sua epoca, e in Phädras Ehre si fa a un tempo agente e oggetto della sua stessa decostruzione, più che dell’autodistruzione che sta al cuore delle versioni antiche del mito. Fedra sul palco è una dark lady in camicetta bianca, gonna di pelle e tacchi di vernice nera: ricorda certi look androgini di Marlene Dietrich e si impone sulla scena con aria di sfida, fumando una sigaretta dopo l’altra. Neppure per un istante Fedra è una vittima. È un’intellettuale capace di ragionare, incolparsi, discolparsi, giustificare le proprie scelte; sa di essere prigioniera delle parole, quelle che la società le consente: troppo poche, troppo limitate, troppo parziali, per spezzare del tutto i vincoli della relazione con Ippolito, in cui lei si trova suo malgrado coinvolta e che finirà per accettare, ma alle sue condizioni.

La Fedra di Agnese Grieco esiste a prescindere dallo sguardo di Ippolito, ma paradossalmente è proprio il desiderio che la guida all’interno di questo intricato rapporto a renderla pienamente consapevole di sé stessa. Per questo non può fare a meno di sviluppare una forma di ossessione per ciò che sta vivendo, né può smettere di interrogarsi sul proprio desiderio e sul conflitto con le norme sociali e morali cui esso la conduce. La ragione e l’eros parlano lingue diverse, ma è nel fallimento conclamato della prima come guida verso il bene che si annida una nuova possibilità di conoscenza e trasformazione per Fedra: tutto può prendere una piega inattesa se le parole si alleano con il desiderio, o almeno questa è l’idea che la donna comincia ad accarezzare. Infatti, sulla scena la consapevolezza di Fedra non è un dato di partenza: il pubblico assiste alla liberazione di una coscienza, che decostruisce sé stessa e si ricostruisce in forme sempre nuove, attraversa il dolore dell’incertezza e della colpa, decide di non nasconderlo né rifiutarlo e lo porta alle estreme conseguenze. Tuttavia, Fedra all’inizio non sa ancora su quale crinale si troverà a scendere: la sua sfida è piuttosto tentare di vivere il suo desiderio, di trasformarlo e mutare con esso.
L’autodifesa davanti alle donne di Trezene è il momento in cui la Fedra di Agnese Grieco intuisce la possibilità di un nuovo cammino: invece che liberarsi dal desiderio, cercherà di liberarsi attraverso il desiderio, dopo averlo chiamato una malattia e un difetto della volontà alla maniera socratica. È forse un’illusione, quella di potere cavalcare il proprio eros e portarlo in una direzione di creazione e scoperta. Nasce dall’ebbrezza di chi ha compreso che la morale e i ruoli di genere sono una costruzione e tale è anche la colpa della donna che desidera: «Non bisogna voler mettere regole troppo strette alla vita!», esclama, dopo avere valutato con la massima razionalità il peso della vergogna e l’invincibilità del demone che la attraversa. Da questo empito di ribellione, che è una presa di posizione in favore della sperimentazione della vita e del desiderio, Fedra si abbandona alla scoperta del suo corpo: sola sulla scena, balla, fuma, si rotola sul tavolo, come in preda a un orgasmo travolgente.
Da questo momento in poi, nulla sarà più come prima. Se la mente di Fedra non può distogliersi a lungo dall’oggetto del suo desiderio, un nuovo coraggio la spinge a scrivere i suoi sentimenti nero su bianco. A dare voce al suo eros liberato si prestano le parole che Ovidio attribuisce a Fedra nella quarta delle Heroides, dove la donna dichiara di non volere più tacere il suo amore, perché la potenza del dio a questo la spinge e lei è pronta ad accettarlo. Non è che un preludio della dichiarazione, assai più rischiosa, che la aspetta di lì a poco.

Sul fondo del palco, appoggiata a una soglia illuminata, si staglia la figura di Ippolito, interpretato da Campbell Caspary, che nello spettacolo è l’unico personaggio maschile a comparire e a svolgere un ruolo di qualche importanza. Canottiera bianca aderente e pantaloni a zampa, entra in scena facendo acrobazie e flessioni, come un saltimbanco palestrato che più o meno consapevolmente – ma della sua innocenza non si può essere affatto certi – si offre allo sguardo concupiscente di Fedra e del pubblico. Ippolito ostenta il suo corpo oggettificato, che è anche l’unica arma di seduzione di cui dispone, come si apprende appena apre bocca e comincia a esporre la sua visione del mondo. Tutto il suo personaggio è contrassegnato dal falso candore di chi proclama di rifiutare la vita associata e i piaceri di Afrodite, ricercando nella natura e nelle attività presiedute dalla dea Artemide il senso della propria esistenza, ma in fondo smania di essere guardato e desiderato da Fedra. Nel frattempo la donna, accovacciata su una poltrona in un angolo, lo ascolta, lo contempla e cerca la forza per dichiararsi.
La dichiarazione di Fedra a Ippolito non è raccontata nell’Ippolito portatore di corona, ma si trovava probabilmente al centro dell’Ippolito velato, la prima, scandalosa versione della tragedia che Euripide dovette riscrivere, ed è presente anche in Seneca. Il modo in cui la regia di Agnese Grieco inscena lo scambio tra i due personaggi adombra però una relazione ben diversa dalla vergogna e dalla reticenza che nelle versioni antiche si accompagnava allo svelamento del desiderio proibito. Il passaggio, molto sottile, dalla vergogna alla provocazione sta nel tono di divertita sfacciataggine con cui Sophie Rois pronuncia la battuta: «Per te non sono una madre, se vuoi posso essere una sorella, una serva, anzi, meglio, la tua schiava». Fedra sa di affermare qualcosa di pericoloso e forse si aspetta con sottile piacere di essere mortificata da Ippolito, in un rapporto di segno sadomasochistico, di interdipendenza e odio reciproco che nasce dall’impossibilità della separazione.
La reazione di Ippolito, dettata dalla minaccia che egli avverte alla sua virilità, lascia peraltro affiorare un’inversione sorprendente dei ruoli di genere, che ne conferma la fluidità in presenza di un desiderio tanto travolgente. Di fronte alle parole della donna il corpo di Ippolito si irrigidisce, barcolla, cade sul tavolo in una posizione che richiama quella di chi subisce una violenza carnale. Ippolito si inscena come vittima del desiderio di Fedra, per cui ha buon gioco a riversarle contro un discorso misogino, in cui non a caso la più terribile delle sciagure è riconosciuta nella donna dotata d’intelletto, che non ha rispetto per la virtù e la morale, a cui l’uomo si appella per rinsaldare il proprio diritto insindacabile a decidere sulla legittimità del desiderio altrui. La novità è che Fedra, per parte sua, manipola consapevolmente queste aspettative e non esita a volgerle a vantaggio del proprio desiderio, anche a costo di esercitare una forma di potere o costrizione sull’altro. In questo senso, i rapporti tra lei e Ippolito non sono affatto configurati nei termini di una subordinazione di Fedra alla sua controparte maschile e ai valori di cui Ippolito si fa portatore.
È questo uno dei temi centrali dello spettacolo, di cui Fedra si dimostra pienamente consapevole. Il suo desiderio fa i conti con la vergogna che la società è pronta ad addebitarle per il suo gesto imperdonabile, tanto che nella sua manipolazione di Ippolito attraverso le parole, arte in cui è abilissima, non esita ad affermare: «La tua virtù guarda con orgoglio alla mia sofferenza». Fedra sa quale partita sta giocando e fa del suo meglio per vincerla con i mezzi che ha a disposizione. Anche di fronte al rifiuto del figliastro, i pensieri di Fedra non si rassegnano: di certo non è la vergogna a frenare i suoi propositi. In uno scatto di ribellione, rovescia per terra tutti gli oggetti sulla scrivania, come per fare tabula rasa delle convenzioni e di un’identità che non le appartiene più. Tornare indietro a questo punto non è più possibile: non resta che l’extrema ratio, la morte, nel cui dominio Fedra non intende avventurarsi da sola.
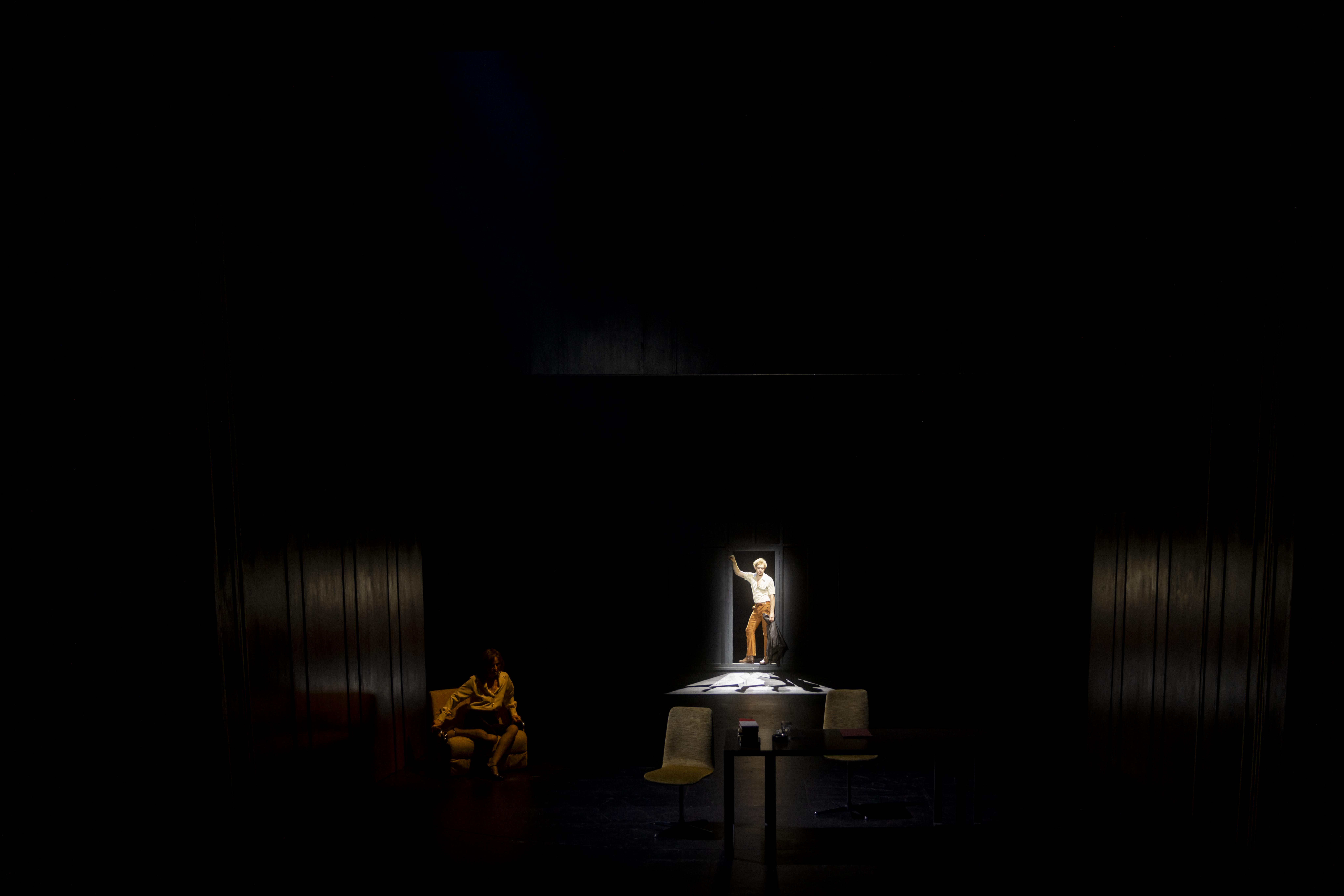
A condurla a questo passo è la logica, che la mette di fronte a un muro. Non può avere Ippolito, ma non può neppure immaginare di tornare alla vita di prima come se niente fosse, perché ciò non le sarebbe consentito, dopo che lei ha svelato tutte le sue carte. Peraltro, come nella versione più scandalosa di Euripide, sarà Ippolito a morire per primo, per mano della conturbante dark lady che ora sente di avere in pugno il destino di entrambi. Non c’è alcuna paura, in lei, che la sua condotta infami il marito e i figli, ma solo la presa d’atto di un’impossibilità di risolvere in altri modi il conflitto che sta vivendo. La Fedra di Agnese Grieco, dopo aver dato fondo a tutte le sue risorse intellettuali, prova un piacere esplicito, misto a disperazione, nel condannare a morte Ippolito e sé stessa: in un quadro sociale che impone l’irrigidimento identitario e codifica comportamenti, parole ed emozioni, l’abbandono alla distruzione è l’estrema presa d’atto dell’inevitabilità dell’eros, che trascina tutti in una più segreta, comune condanna, cui è inutile opporsi; ma è anche l’esercizio di un potere di cui Fedra finalmente si appropria.
È questo l’ultimo atto della liberazione di Fedra dalla sua identità precedente di moglie e madre. Le luci del palco si accendono, la scenografia si solleva; dietro le quinte, dall’altra parte della scena ormai sgombra, si apre una sala identica a quella in cui siede il pubblico, ma vuota, verso cui Fedra si incammina, senza mai smettere di parlare e ragionare. Come in Winterreise di Elfriede Jelinek, la protagonista svanisce gradualmente dall’orizzonte del pubblico: il suo corpo si allontana, la voce si affievolisce, ma Fedra non cessa per questo di riflettere su di sé fino all’ultimo istante, per quanto il suo discorso sia ormai incomprensibile. È allora una dea, probabilmente Artemide, a ritornare dal pubblico e ricordare che è stata Afrodite a stregare l’anima di Fedra con la passione proibita, la follia d’amore, e che la donna ha infine trovato la morte. Se poi Fedra sia morta davvero, o si tratti dell’ennesimo inganno di chi ha raccontato la sua storia al posto suo, rimane poco chiaro: ciò cui il pubblico assiste è piuttosto una sparizione, l’estremo sottrarsi di Fedra alle aspettative altrui e la riaffermazione di una libertà tragica. Fedra ha potuto concepire e operare anche il male con la massima consapevolezza, in nome di un desiderio irrefrenabile che è più potente di qualsiasi norma sociale.
Per le foto @Luna Zscharnt