Nel discorso pronunciato stamattina da Mario Draghi, la situazione che stiamo vivendo è stata definita, con un’immagine efficace, ‘tragedia’:
«Alcuni pensano che la tragedia nella quale abbiamo vissuto per più di 12 mesi sia stata simile ad una lunga interruzione di corrente. Prima o poi la luce ritorna, e tutto ricomincia come prima.»
L’immagine usa, in maniera più concreta e adeguata al XXI secolo, la metafora del buio e dell’aspettativa della luce, come quando si attraversa un tunnel. Per noi quest’immagine è particolarmente significativa, poiché in tutte le riflessioni su questo blog ci riferiamo al termine tragedia nel suo primo significato, ossia tragedia come genere letterario. Proprio il genere letterario ci insegna che ad una tragedia non può mai seguire il ristabilimento dell’ordine precedente, ma un nuovo ordine, un nuovo inizio; e che ogni tragedia nasce come conseguenza di un’azione sbagliata, di un atto di ingiuria morale, di una colpa di superbia e di arroganza, di un cattivo uso della ragione; nasce come conseguenza prolungata nel tempo, che attraversando le generazioni travolge anche chi a rigore non può dirsi colpevole.

Proprio nell’attenzione al succedersi delle generazioni, sta un altro fondamentale elemento tragico del discorso di Draghi. Nella definizione del programma di uscita dalla pandemia come Next Generation EU, c’è una sorta di retorica delle generazioni e anche una precisa filosofia della storia che vede il succedersi delle generazioni come progresso. L’innovazione passa o dovrebbe passare sempre per un rifiuto e una correzione del passato, nell’arte come nella politica, ma non è un processo indolore.
Se torniamo alla tragedia è proprio perché anche in questo la storia di Atene nel V sec. a.C. in qualche maniera è paradigmatica: nel contrasto tra Emone e Creonte nell’ Antigone , in quello tra Odisseo e Neottolemo nel Filottete, solo per fare due esempi celebri (che dovrebbero essere celebri), si nasconde in filigrana un dissidio politico, che ha al centro il governo della città.
Le generazioni dunque si oppongono, non si susseguono armonicamente: basti pensare agli atti d’accusa di Greta Thunberg, basti pensare ai movimenti di protesta giovanili in tutto il mondo, gli esempi sono tanti e tutti significativi. I padri sono messi sotto accusa, e non esaltati e posti a modello, il che è invece caratteristico, da Omero in poi, di una mentalità conservatrice, per cui i padri sono considerati migliori dei figli. E così è stato, anche se dubitativamente, in un passaggio cruciale del discorso di stamattina:
«Spesso mi sono chiesto se noi, e mi riferisco prima di tutto alla mia generazione, abbiamo fatto e stiamo facendo per loro tutto quello che i nostri nonni e padri fecero per noi, sacrificandosi oltre misura. È una domanda che ci dobbiamo porre quando non facciamo tutto il necessario per promuovere al meglio il capitale umano, la formazione, la scuola, l’università o la cultura».

Mario Draghi, ha dovuto chiarire: ‘loro’ sono i giovani, la next generation, appunto. Per semplificare, è evidente che il Primo Ministro ha saltato la generazione di mezzo, la mia, quella cioè che non vedrà quasi certamente il 2050, l’anno in cui l’Europa ha fissato il termine per zero emissioni di CO2, ma che pure è separata da almeno vent’anni dalla generazione di Draghi. Bisogna far di tutto, dunque, ha continuato Draghi, «nella speranza che i giovani italiani che prenderanno il nostro posto, anche qui in questa aula, ci ringrazino per il nostro lavoro e non abbiano di che rimproverarci per il nostro egoismo».
Di sicuro, in piena tragedia, quest’idea armonica del succedersi delle generazioni, vale come rassicurazione e di rassicurazione abbiamo bisogno.
In ogni tragedia, però, come dicevamo, i padri sono i colpevoli, coloro che portano la responsabilità dell’inizio di ogni catena di sventura o maledizione: è curioso che la maggior parte degli esponenti della generazione di Draghi, nata tra il ’40 e il ’50 del secolo scorso, negli anni Settanta non ebbe affatto riconoscenza nei confronti dei padri, non ne riconobbe i sacrifici e nemmeno l’eredità. È stato proprio negli anni Settanta che il conflitto tra generazioni ha dato adito ad altre tragedie, quelle del terrorismo, le cui cicatrici sociali sono ancora visibili, e che non devono essere perciò dimenticate.
Anche le lotte degli studenti, degli operai, degli intellettuali contro un sistema che fagocitava la creatività, la fantasia e creava disuguaglianze palesi, sono proprio della generazione di Draghi, sepolte poi dal riflusso nel privato, dalla confusione ideologica, e dal prevalere di stili di vita improntati all’apparenza, alla produttività, all’immoralità degli anni ’80. La generazione di Draghi, che è già quella dei nonni e non quella dei padri, avrebbe sì dovuto farsi queste domande, ma non adesso, durante la tragedia della pandemia, avrebbe dovuto farsele ben prima, quando si sono affermati modelli che hanno portato la ‘formazione, la scuola, l’università e la cultura’ su binari altri e devianti rispetto alla tradizione umanistica occidentale, quando l’orgoglio patriottico, a cui adesso ci si richiama, era molto difficile da provarsi per la situazione politica, economica, morale e culturale in Italia. Correvano gli anni delle connivenze Stato mafia, della corruzione e delle mani pulite, delle caste e dei sistemi. Questo hanno dato alla mia generazione i padri. Ora: tutto si può rivedere e superare, ma non dimenticare.
E veniamo al presente, alla next generation che aspetta il miracolo educativo ed economico. Abbiamo dei soldi da spendere. Qui il discorso di Draghi, per il resto chiarissimo nonostante l’emozione, diventa tragicamente oscuro:
«È necessario investire in una transizione culturale a partire dal patrimonio identitario umanistico riconosciuto a livello internazionale.»
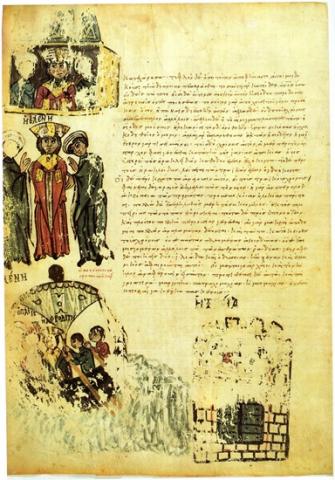
Cosa vuol dire transizione culturale? Che quel patrimonio umanistico identitario (identitario per chi? Per noi italiani? Per noi europei? Per gli occidentali?) deve trasformarsi in altro? Naturalmente qui il discorso ha toccato corde per noi vibranti: in che senso l’umanesimo è un patrimonio? In senso metaforico? O in senso quantificabile, perché produce, invece che conoscenza, capitale? Ma soprattutto ci spaventa un po’ il fatto che tale ‘patrimonio’ sia ‘riconosciuto a livello internazionale’: non capiamo bene quale sia il metro di misura, il criterio di valore, per cui ciò che possediamo, e che rientra nella categoria dell’umano, sia riconosciuto da altri che sono ugualmente uomini. Esistono patrimoni umanistici identitari? Ogni volta che la storia li ha visti nascere sono stati dolori, perché il riconoscersi speciali rispetto ad altri uomini è volente o nolente il primo seme del razzismo.
Di sicuro questa pandemia sta facendo nascere un nuovo concetto di umanesimo: quello per cui si deve salvare chi ha maggiore aspettativa di vita e non chi è più in pericolo, quello per cui le disuguaglianze sono tollerate in base alle esigenze economiche, quello per cui la macchina post-umana svolge le stesse funzioni o quasi dell’umano, quello per cui le competenze umanistiche possono essere pensate come contorno a quelle scientifiche in un percorso educativo che si adegui a standard di alta utilità. In tutto questo, non sarà sfuggito l’invito a spendere i finanziamenti destinati agli istituti tecnici.
Qui Draghi è stato preciso:
«E’ stato stimato in circa 3 milioni, nel quinquennio 2019-23, il fabbisogno di diplomati di istituti tecnici nell’area digitale e ambientale. Il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza assegna 1,5 md agli ITIS, 20 volte il finanziamento di un anno normale pre-pandemia. Senza innovare l’attuale organizzazione di queste scuole, rischiamo che quelle risorse vengano sprecate.»
Tre milioni di diplomati, dunque, nell’area digitale e ambientale, a cui si promette subito l’inserimento nel mondo del lavoro, e che perciò non frequenteranno l’università, perché non ne avranno il tempo. Non possiamo sprecare 1,5 miliardi di euro, siamo d’accordo. Non possiamo sprecare nemmeno un euro, in un momento in cui la povertà uccide ormai più del virus. Eppure questa idea di percorso formativo, la centralità degli istituti tecnici, il modello francese e tedesco additato da Draghi (dove però le élites continuano a frequentare i ginnasi ‘umanistici’) ci lascia un po’ impauriti, se ci è data la libertà di impaurirci.
Come pure l’idea che la ricerca di base abbia senso, o abbia più senso, se ‘punta all’eccellenza’: qui il discorso diventa più ampio. Vogliamo dire solo questo: la ricerca è un’attività infinita, che coinvolge il ricercatore dal punto di vista emotivo e razionale, ne condiziona l’esistenza; la ricerca è una missione e un’arte lenta, lentissima, che non può dare certezze e si basa sull’esperimento, sulla prova, sull’errore. L’eccellenza della ricerca non è un obiettivo che ci si può porre a priori, lo si raggiunge per una serie di circostanze, alcune anche casuali, con un lavoro paziente, per nulla eccellente, alcune volte persino ripetitivo, seguendo pratiche consolidate e cambiandole a poco a poco lì dove non danno risultati. Ogni ricercatore lo sa, in ogni campo del sapere. Ogni ricercatore lo sa, ogni ricercatore che svolga la sua attività con amore, un sentimento difficilmente compensabile, quantificabile e che non si può esigere o si può prenotare o comprare. Ogni ricercatore che studia, verbo che esprime un desiderio infinito di conoscenza, lo sa. Ogni ricerca ha dunque al centro l’uomo, e non tanto il capitale umano, cioè quel che l’uomo vale o può valere, ma il fattore umano. Solo questa ricerca, col tempo e in maniera imprevedibile, è capace di creare nuove ‘visioni’ del mondo, e le scelte coraggiose auspicate oggi da Mario Draghi.
Chi non è capace di questa ricerca, che è quantificabile e visibile anche quando non è eccellente, sì, costui lo vorremmo fuori dall’Università. E qualcosa risparmieremmo.

