Leonardo Sciascia nell’Affaire Moro (1978) avanzò il dubbio che la vicenda del rapimento e dell’esecuzione di Aldo Moro corrispondesse a un copione già scritto e che non ci fosse stato alcun vero dilemma politico nel rifiutare la trattativa con le Brigate Rosse, ma un disegno, per il quale al governo italiano del tempo convenne sin da subito l’assenza e non la presenza di Moro.

Il libro di Sciascia, scritto a ridosso dei fatti, pur breve, è di scrittura densissima e non facile. Per giungere al nocciolo bisogna seguire gli itinerari precisi, taglienti dell’argomentazione e l’analisi puntuale dei documenti allora disponibili. Di quel libro resta più che mai attuale la tesi ispiratrice, tratta da un celebre racconto di Jorge Luis Borges (Pierre Menard, l'autore del Chisciotte), per cui la verità storica non è mai ciò che avviene, ma ciò che noi giudichiamo sia avvenuto, secondo come ci è raccontato.
Rispetto al caso specifico, come in un giallo, Sciascia cerca il colpevole e il movente, cercando di rispondere alla domanda: da chi fu davvero condannato Aldo Moro? Dalle Brigate Rosse o piuttosto da quello Stato che rifiutò ogni trattativa con i brigatisti?

Il progetto delle Brigate Rosse, con il rapimento del Presidente del consiglio incaricato, ebbe esplicitamente per scopo impedire quel che allora era stato definito ‘compromesso storico’, ossia il ritorno del Partito Comunista al governo affianco alla Democrazia Cristiana. Proprio la mattina in cui fu rapito, Aldo Moro si stava per rendere artefice di quella nuova fase della storia del governo repubblicano.
Paradossalmente, i giorni della prigionia e poi l’esecuzione di Moro subirono l’effetto opposto a quello voluto dai terroristi, nota Sciascia: sin da subito, infatti, le bandiere rosse del Partito Comunista si unirono a quelle bianche scudocrociate della Democrazia Cristiana in una solidarietà che mai si era vista nelle piazze italiane. L’assenza di Moro, perciò, convenne sin dal primo momento allo Stato italiano, più che la sua presenza. Da qui – deduce Sciascia - il rifiuto da parte dello Stato di trattare, fatto passare per intransigenza e fedeltà alla ragion di Stato.
Moro fu dunque vittima di un calcolo di opportunità politica, secondo Sciascia, vittima dunque dei suoi stessi ‘amici’ al governo, ma poiché la responsabilità di quel calcolo non poteva ricadere su chi lo architettava, essa fu data addirittura alla letteratura e alla finzione, a chi aveva già raccontato le trame oscure del potere, e perciò istigato alla loro sovversione, mettendosi implicitamente dalla parte dei brigatisti. Sciascia, invero, si riferisce a Pier Paolo Pasolini e poi a sé stesso, in particolare a Il contesto e Todo Modo che Elio Petri aveva trasformato in film (1976).
Lasciata […] alla letteratura la verità, la verità – quando dura e tragica apparve nello spazio quotidiano e non fu più possibile ignorarla o travisarla – sembrò generata dalla letteratura. Dagli uomini politici del potere, o al potere vicini, gli uomini di lettere (preferibile ‘uomini di lettere’ – di Voltaire e del suo tempo – a ‘intellettuali’, termine di generica e imprecisa massificazione) ne furono accusati: e con una certa buona fede, con una certa innocenza, considerando che gli stessi uomini di lettere avrebbero a un certo punto avuto l’allucinazione di aver generato quella realtà.

Il caso Moro pone dunque lo scrittore Sciascia davanti al paradosso per cui sembra che la realtà prenda ispirazione dalla finzione, e che questa abbia valore profetico. Per distruggere l’idea che l’invenzione abbia prevalso sulla realtà, Sciascia decostruisce la narrazione della vicenda Moro, mettendo in luce dove non tiene.
Sembrò allora e dopo che non ci fosse un solo Aldo Moro, ma due: uno durante il ‘processo’ da parte delle Brigate Rosse, quando Moro è ancora un personaggio pubblico; e dopo la condanna, tra la sentenza e l’esecuzione, quando lo statista ha vissuto in una sua sfera di sentimenti e risentimenti ormai assolutamente personali, assolutamente privati. Lo mostrano le sue lettere, alcune rese pubbliche nonostante la richiesta di segretezza da parte di Moro, perché nulla si poteva nascondere al popolo secondo il tribunale rivoluzionario; altre, invece, tenute segrete, rispettando il prigioniero in attesa di esecuzione: eppure per recapitare quei biglietti, che talora contenevano solo frasi affettuose, i terroristi rischiarono la vita, evidentemente ritenendole importanti al pari dei messaggi dell’uomo di Stato. Paradossalmente, perciò, furono i brigatisti a rispettare Aldo Moro e i suoi principi, tra cui quello così chiaramente espresso in una lettera a Francesco Cossiga:
Il sacrificio degli innocenti in nome di un astratto principio di legalità, mentre un indiscutibile stato di necessità dovrebbe indurli a salvarli, è inammissibile.

Sciascia riesce a mostrare la profonda coerenza di stile e soprattutto di pensiero tra l’uomo che chiede allo Stato di trattare per salvargli la vita mentre è nelle mani delle Brigate Rosse, e il politico e teorico della politica che sino al 16 marzo 1978 aveva esercitato il potere.
La ‘narrazione’ del caso Moro fu giocata sul contrasto tra uno Stato intransigente, che non può tener conto del particolare se non a rischio di mettere a repentaglio la propria esistenza, e le ragioni dell’individuo, che possono spingere all’umana pietà ma non hanno giustificazione politica. E qui Sciascia incide più profondamente il suo bisturi dell’analisi. Quale Stato, chiede?
La politica della fermezza fu all’epoca perorata da uno Stato alla cui integrità morale non credeva più nessuno, uno Stato cioè che da più di un secolo conviveva con le forme di criminalità organizzata e da trent’anni coltivava la corruzione e l’incompetenza. Quello Stato applicava al caso Moro «il peggior rigore comunista» in un «paese scombinato come l’Italia», scrive lo stesso Moro alla moglie. In nome dell’amore per lo Stato si svolse, nei giorni della prigionia di Moro, un melodramma, ironizza Sciascia, finito però in tragedia, perché Aldo Moro ne fu vittima, con la sua scorta.

La fermezza dello Stato non era credibile, denuncia Sciascia, poiché minata dalla corruzione di quello Stato, dal fatto che i suoi esponenti in pubblico non erano quel che erano in privato, uno Stato in cui trasparenza e rigore restavano esigenze svuotate di ogni contenuto e di ogni esperienza. Si apriva così la questione dell’etica pubblica, che impresse una svolta epocale alla storia politica italiana, su cui qualche anno fa ha scritto un libro Gianfranco Pellegrino, nelle cui pagine la posizione di Sciascia nell’Affaire Moro assume una posizione storiograficamente centrale.
E la scomoda posizione di Sciascia allora fu: il sacrificio per lo Stato ha senso quando lo Stato lo merita. Non era però quello il caso dello Stato italiano a metà degli anni ’70, colluso con la mafia, il banditismo, altre associazioni criminali o illegali.
Uno Stato del genere lo si deve combattere, ed era questa la posizione dei cosiddetti ‘simpatizzanti’ con il terrorismo di sinistra, in Italia e in Germania. Gli intellettuali tedeschi in particolare riconoscevano le ragioni dei terroristi perché come loro vedevano nello Stato capitalista una propaggine dello Stato nazionalsozialista, l’espressione malata della stessa borghesia industriale che schiacciava l’essere umano, lo mercificava, lo usava al pari delle macchine. Uno Stato del genere andava combattuto, non si poteva morire per esso. In Germania, per raccontare questo stato delle cose, ricorre spesso in quegli anni il tema di Antigone.

L’ Antigone di Sofocle, la tragedia del contrasto tra leggi dello Stato e leggi private, intime, dell’individuo, servì, durante gli anni di piombo, per narrare la contrapposizione tra Stato e individuo, contrapposizione che è com'è noto il perno della lettura della tragedia da parte di Hegel: da una parte stavano coloro che erano per Antigone, intesa non come la vittima innocente, ma come colei che ha la capacità di minare lo Stato con la sua disubbidienza, controfigura delle ragazze emancipate politicamente attive e ideologicamente consapevoli, che manifestavano insieme ai compagni maschi e non si accontentavano più di un ruolo ‘da donna’ imposto socialmente da secoli; per Antigone erano dunque i ‘simpatizzanti’, gli intellettuali di sinistra a cui venne poi attribuito il disfacimento morale e l’aver giustificato la violenza della guerriglia urbana. Dall’altra parte stavano coloro che comprendevano le ragioni di Creonte, dell’autorità costituita, del voler tutelare le fondamenta dello Stato e la sua stabilità contro i tentativi eversivi, che si avvalevano dell’etica del non cedere ai ricatti ideologici: per costoro il trapasso dallo stato nazionalsocialista alla Repubblica Federale Tedesca poteva dirsi indolore, perché le loro funzioni e i loro ruoli erano spesso rimaste intatti.
Proprio mentre in Germania la figura di Antigone trapelava nelle narrazioni del fenomeno del terrorismo, in Italia il caso Moro e la tragedia di Moro in quanto essere umano complicava molto una rappresentazione dualistica della società, ed era questo l’avvertimento di Sciascia.
Moro rappresentava, infatti, quello Stato di cui era diventato vittima, non ne era antagonista, e dunque proprio la sua tragedia metteva in crisi una rappresentazione troppo lineare della contrapposizione tra ragioni dello Stato e ragioni dell’individuo, tra collettività e individuo.
A livello simbolico, nella disgraziata vicenda di Moro le ragioni di Creonte e quelle di Antigone venivano a coincidere, proprio perché Moro era a capo di uno Stato che non aveva alcuna autorità morale, e contro il quale ora, in una posizione inaspettatamente subordinata, protestava, come Antigone, in nome della Giustizia e della libertà individuale, per salvare se stesso.

Certo il modello Antigone funzionava e funziona anche per molti altri aspetti della vicenda Moro, possiamo aggiungere: la vicinanza alla morte dell’uomo Aldo Moro, incarnazione secondo alcuni di un pessimismo meridionale che lo rendeva incline alla morte e che aveva trovato simbolica realizzazione nei giorni di prigionia delle Brigate Rosse trascorse in bilico tra la speranza e la condanna; l’ingiustizia e l’oscurità della segregazione, di cui le immagini della polaroid raccontavano tutta l’irredimibile malinconia; l’intervento inutile dell’autorità religiosa, il Papa, una specie di Tiresia troppo connivente con il potere. Anche nelle lettere di Moro pare risuonare l’invito di Tiresia a Creonte (al Potere) a tirarsi indietro rispetto alle decisioni prese, per evitare il peggio (che d’altronde è inevitabile, perché Moro, come Tiresia, oscuramente lo profetizza). Moro poi impersonava, come scrive Sciascia, le ragioni della ‘famiglia’, intesa nel senso più allargato nel termine, secondo la sua idea per cui lo Stato diventa famiglia, non trascende o trascura l’individuo o il particolare, ma lo interpreta: quel che invece non si realizzò nel destino personale di Moro, in cui lo Stato prese le distanze dall’individuo e lo disconobbe (come Creonte disconobbe Antigone in quanto sua nipote, parte della sua stessa famiglia).
Moro, dunque, come Antigone, vittima sacrificale, schiacciata da uno Stato indifferente alle ragioni dell’uomo? Non proprio, dicevamo: perché Moro impersonava quello Stato, si trova ad essere Creonte e Antigone contemporaneamente, o almeno un’Antigone del tutto corresponsabile delle scelte di Creonte e delle sue intenzioni. Di questa insolubile ambiguità, che nel teatro post-bellico era stata indicata da Bertolt Brecht nella sua Antigone ‘che mangia del pane cotto nella grotta oscura del potere’, non tengono sempre conto le narrazioni successive a Sciascia del caso Moro.

Ad esempio nel romanzo-memoriale Il desiderio di essere come tutti di Francesco Piccolo, vincitore del Premio Strega 2014: durante il rapimento Moro, scrive Piccolo, «man mano che i giorni passavano, il simbolo dello Stato arretrava, l’essere umano avanzava in primo piano per i cittadini che assistevano allo strazio senza poter fare nulla». Ancora, dunque, una narrazione che distingue nettamente l’uomo di Stato dall’uomo privato. Proprio questa distinzione ha fatto sì che col tempo (quindi in sede di ricostruzione e rivisitazione dei fatti) si sia fatta strada l’idea che non si sia voluto salvare Moro. Ma la fermezza dello Stato – argomenta Piccolo – non ha nulla a che vedere con il doloso e torbido disegno di liberarsi di Moro, sebbene il sospetto che questo disegno vi fosse si è abbarbicato, col tempo, sulla fermezza, che era invece giustificata. La mancanza di volontà, dolosa, di salvare Moro, ha contaminato come un parassita la scelta dello Stato di restare sulle proprie posizioni. Perciò il ‘caso Moro’ resta, nella storia italiana, segnato dalla confusione e dall’incertezza: perché due diversissimi fatti si sono mescolati tra loro, diventando una sola cosa. La fermezza dello Stato è diventata insomma torbido disegno per eliminare Moro.
Ma la scelta della fermezza era, considera ancora Francesco Piccolo, limpida e moralmente solida. Discutibile quanto si vuole, perché come per lo scontro tra Creonte ed Antigone, si può propendere per la superiorità del bene pubblico sulla pietà umana, o per la superiorità della pietà umana sul bene pubblico. Ed è, come nella tragedia di Sofocle, un’opposizione inconciliabile, il punto dove una sola delle ragioni può sopravvivere. In quel momento storico, poiché nei confronti di Moro prevalse l’idea del bene pubblico (Creonte), passato del tempo e per lenire il senso di colpa sappiamo dire soltanto le ragioni di Antigone. Soprattutto perché non abbiamo mai creduto all’onestà di tutti i Creonte. Ma l’errore che si fa ora è quello di tenere dalla stessa parte – e anzi di rendere confuse in un solo pensiero – la fermezza e la volontà di far tornare Moro vivo.
Un errore? Quell’errore non fu affatto di Sciascia, che più lucidamente nella sua indagine indiziaria sulle ragioni di un omicidio insinua il dubbio che la morte di Moro convenisse più della sua liberazione ad uno specifico progetto politico. Si voleva davvero far tornare Moro vivo? – chiede Sciascia. Forse no. Né si può ignorare che quello Stato, contro cui combattevano le Brigate Rosse, trasse solo vantaggi politici dalla morte di Moro, e che anzi proprio attraverso questa sconfisse il terrorismo: le Brigate Rosse fallirono, mancarono il loro scopo, che era impedire e non favorire l’azione di avvicinamento della Democrazia Cristiana al Partito Comunista. Se dunque la volontà di far tornare Moro vivo non ci fu, allora la cosiddetta 'fermezza' fu il suo strumento. Non è un errore pensarla così; è una possibilità.

Ma quel che qui e oggi in generale ci interessa è piuttosto, anche al di là della tragedia di Aldo Moro, il chiedersi insistente da parte di Sciascia cosa sia il Potere, il Potere che non si mostra, che sta in una zona d’ombra, protetto da oscurità impenetrabili, inaccessibili da chi crede di vedere e invece non vede.
E le parole di Sciascia, anche queste parole di Sciascia, restano e riecheggiano oggi, più importanti che mai, il giorno dopo l’assalto del Campidoglio statunitense, in un’età segnata ancora dal terrorismo e dalla paura: le parole che chiedono conto della natura del potere, delle sue trame occulte, della impossibilità di penetrarvi. «Io non desidero attorno a me» - aveva scritto Moro quando ormai era certo di dover morire - «uomini di potere». E il commento di Sciascia:
E infine, ecco, c’è la parola che per la prima volta scrive nella sua più atroce nudità; la parola che finalmente gli si è rivelata nel suo vero, profondo e putrido significato: la parola «potere». (…) Per il potere e del potere era vissuto fino alle nove del mattino di quel 16 marzo. Ha sperato di averne ancora: forse per tornare ad assumerlo pienamente, certamente per evitare di affrontare quella morte. Ma ora sa che l’hanno gli altri: ne riconosce negli altri il volto laido, stupido, feroce. Negli «amici», nei «fedelissimi delle ore liete»: delle macabre, oscene ore liete del potere.
Non vogliamo dire che la lettura di Sciascia sia giusta, non ne avremmo le competenze storiografiche. Ma non pensiamo nemmeno con Francesco Piccolo che il dubbio si abbarbichi sulla vicenda Moro contaminandola, perché la fermezza dello Stato era invece sicuramente giustificata. Come per la tragedia di Sofocle, si possono trovare ragioni anche per la fermezza di Creonte e per il suo editto: ma queste ragioni non tengono alla luce di una moralità libera, non asservita al potere, a nessun potere. Si può dubitare che Antigone impersoni tale moralità. Ma resta l'interrogativo su cosa sia il Potere che determina le azioni dell'uno e la ribellione dell'altra.
Il problema al centro del ‘copione Moro’ come uno degli eventi di cesura della storia italiana è la natura del Potere, i mezzi di cui questo si serve per ottenere i suoi scopi, la maniera con cui il Potere riesce a penetrare nelle coscienze degli individui al punto da far ritenere normale l’asservimento. Il caso Moro, in una rilettura che si serve delle categorie dell’Antigone fa riflettere non perché ancora una volta ci pone davanti alla scelta da che parte stare, ma perché mette in luce la pericolosità, l’ambiguità, l’imperscrutabilità del potere e delle sue trame.
Dove si trova, se c'è, il punto di equilibrio tra Potere e individuo, tra stato di eccezione o di necessità e umana comprensione e pietà? Esiste un Potere che si fa voce dei singoli, o il Potere è di per sé un meccanismo che schiaccia, asservisce, distrugge? Come si diventa inconsapevolmente strumenti del Potere?
Moro pensava, scrive Sciascia, in virtù del suo essere cristiano «che tra il salvare una vita umana e il tener fede ad astratti principi si dovesse forzare il concetto giuridico di stato di necessità fino a farlo diventare principio: il non astratto principio della salvezza dell'individuo contro gli astratti principi.» Abbiamo bisogno di sottolineare l'attualità di queste parole, in un'epoca segnata da nuovi stati di necessità e di eccezione, che sembrano succedersi senza tregua?

La salvezza dell'individuo contro astratti principi, la macchina del Potere (di ogni Potere) che stritola e annienta la libertà: questi temi tornano in un film sulla vicenda Moro prodotto 25 anni dopo i fatti, Buongiorno, notte di Marco Bellocchio (2003).
Non ci sembra perciò un caso se Umberto Curi ha avvicinato questo film, liberamente ispirato dal libro Il brigatista (1988) di Anna Maria Braghetti, al primo celebre stasimo dell’Antigone: nell’Antigone, il coro magnifica le possibilità dell’uomo, il suo essere tremendo nel saper dominare con la tecnica le forze della natura, ma si piega ad una malinconica considerazione su come ogni progresso si arresti davanti al limite insuperabile della morte. Così tutto il film di Bellocchio si configura come una meditatio mortis e una riflessione sulla pericolosità dell’essere umano, sulle sue straordinarie e violente possibilità, ma anche sulla sua ineludibile fragilità.
Come nell’Antigone di Sofocle, il nucleo tematico del film è la sepoltura: il film si apre infatti con le immagini televisive dei corpi degli uomini della scorta di Moro sull’asfalto, di cui uno pietosamente coperto con un lenzuolo, e poi con i loro funerali solenni. Si chiude con le immagini, ancora alla TV, dei funerali di Moro, funerali di Stato a bara paradossalmente vuota a cui tutti gli uomini politici che hanno segnato la storia recente d’Italia sono presenti, ma a cui volutamente manca la famiglia. Al centro del film, in una delle rare scene all’aperto, il rito funebre commemorativo del padre della terrorista protagonista del film, che ogni anno depone fiori freschi sulla sua tomba.
La vicenda di questa Antigone si svolge in bilico sul confine sottile tra la vita e la morte, non solo perché la terrorista rischia in ogni momento di morire, uccisa dalla polizia, ma anche perché intorno a lei e nella sua vita c’è morte e si svolgono riti di morte. Una figura del limite, dunque, un ‘cadavere ancora vivo’, secondo la nota lettura che Jacques Lacan ha dato di Antigone: e per questa condizione simile proprio ad Aldo Moro tenuto in balia dalle Brigate Rosse.

Ma le cose non stanno semplicemente: perché forse sulla falsariga della ricostruzione di Leonardo Sciascia, tra la terrorista protagonista e il prigioniero si instaura un gioco di rispecchiamenti e quasi di identità, sì che alla fine i due personaggi non si contrappongono tra loro, ma sono due diversi volti di vittime di poteri oscuri, che li trascendono, in cui si sono trovati coinvolti per una fede cieca ma in certo senso ingenua. Sono due esseri umani che vanno al sacrificio senza che ne valga la pena, l'uno schiacciato da quello Stato a cui ha persino fatto da guida, l'altra da una comunità sviata da falsi valori, l'una e l'altro emarginati dai loro stessi amici, l'una e l'altro ciechi rispetto a trame complessive. Antigone e Creonte, ambedue colpevoli, ambedue innocenti, che vivono sino in fondo la loro rispettiva tragedia.
Il film si svolge quasi tutto in un interno, l’ appartamento dove Moro è rappresentato prigioniero in una cella ricavata dietro una libreria, dal momento del rapimento sino all’epilogo. La protagonista narrativa è la donna (Maya Sansa) che fa parte del gruppo di brigatisti che tiene recluso Moro (Roberto Herliztka), la quale nei giorni del sequestro continua a lavorare come bibliotecaria e quindi a uscire dal covo.
All’esultanza iniziale, apprendendo in televisione che l’azione del commando era riuscita e Moro era stato rapito con l’eccidio della scorta, segue, da parte della donna, lo sconcerto. L’uomo-simbolo, il presidente della DC, il rappresentante dello Stato corrotto che il proletariato deve rovesciare, si rivela da subito un uomo anziano con le costole rotte e difficoltà di respiro. La donna accoglie turbata la condanna a morte comminata dal ‘tribunale del popolo’ all’uomo politico democristiano. Chiara, questo il nome della giovane di 23 anni, che nel nome aspira alla luce di cui invece è concretamente privata nel buio del covo e nel buio ideologico, osserva dallo spioncino della cella il prigioniero, e lo coglie nei suoi atteggiamenti più disperati, nei nervosismi, nei tic, nella stanchezza; ne contempla insomma la fragilità, ne considera con umana pietà la condizione sempre più inerme e abbandonata. Alla fine concede al prigioniero la possibilità di liberarsi, lasciando aperta la porta della stanza del recluso, dopo aver somministrato un potente sonnifero ai suoi compagni.
Nelle ultime scene del film, infatti, Moro va via dall’appartamento, mette il cappotto, cammina, per una piovosa e bigia alba, verso la vita. Sogno o realtà? Restando puramente sul piano del film, lo spettatore non saprebbe rispondere. Ma i fatti accaduti fanno sì che la soluzione sia interpretata dal pubblico come un sogno, come un puro desiderio di Chiara, che frattanto si è dissociata dalla soluzione violenta dei suoi compagni, ma non ha potuto evitarla se non nella fantasia.

L’appartamento privo di luce, tenuto costantemente all’oscuro per coprirsi da sguardi indiscreti, evoca di per sé una tomba, e contiene, nello strettissimo spazio ricavato dietro una libreria per ospitare il prigioniero, la simbolica urna che ospita un corpo alla soglia della morte. L’appartamento/covo diventa d’altro canto la metaforica tomba degli ideali, della fede e della fiducia di Chiara nel progetto politico a cui ha dato la sua incondizionata adesione. Diventa cioè la sua stessa prigione, oltre che la prigione di Moro. Tanto che nel sogno della liberazione del prigioniero, quest’Antigone alla rovescia, che non vuole seppellire i morti ma vorrebbe restituirli alla vita, rappresenta anche la liberazione dalle proprie angosce, la soluzione alla propria sconfitta, la catarsi dopo la scoperta della propria impurità.
L’archetipo narrativo del mito di Antigone si rende riconoscibile in filigrana nella figura della giovane idealista, che si oppone al potere costituito che considera ingiusto e crede di lottare per un più alto ideale di giustizia e di equità sociale. Chiara, come Antigone, rappresenta poi la sorella per antonomasia: con gli uomini del commando ha invero un rapporto sororale, non macchiato cioè da alcuna commistione sessuale, pur dormendoci insieme: in una scena, nel sonno involontariamente tocca la mano di un compagno che le è disteso affianco nel letto e gli chiede immediatamente scusa. Pur condividendo le idee delle Brigate Rosse, non partecipa alle azioni; recita anzi per copertura la parte della moglie di uno di loro, li accudisce (Moro capisce che c’è una donna ‘da come sono piegate le calze’), attende ai lavori e al ruolo femminile, subordinata senza discutere ad una struttura gerarchica maschilista. Enzo (Paolo Briguglia), collega e corteggiatore, le dice che «si veste come una suora», mortificando la propria bellezza.
Con la figura simbolica di Antigone, Chiara non condivide solo l’algidità, ma anche la mancanza di una famiglia regolare, un’infanzia segnata dalla morte del padre partigiano e da quella prematura della madre: le resta solo il fratello. Nell’unica scena familiare del film, Chiara officia al culto dei morti, al rito del ricordo del padre a cui gli amici, ad ogni anniversario della scomparsa, rendono omaggio davanti alla tomba. Al rito presenzia, senza convinzione, il fratello, ma anche Enzo, che si è prestato a giocare il ruolo del falso fidanzato, per salvare le apparenze davanti alla zia che desidera per Chiara una vita ‘normale’. Possiamo intravedervi in filigrana la controfigura di Emone.
Il personaggio di Enzo è comunque decisivo nel film: è lui infatti l’autore di un copione che come il film s’intitola Buongiorno, notte. Moro ha quel copione nella borsa al momento del rapimento: i terroristi lo aprono e distrattamente ne leggono il titolo.
Forse l’idea deriva dalle tesi di Sciascia, per le quali la vicenda Moro era stata fatta corrispondere ad un copione già scritto, incolpando addirittura gli intellettuali di aver previsto e dunque in qualche maniera originato quello che sarebbe accaduto. Bellocchio, con l’inserzione del copione nella vicenda del film, difende invece la letteratura e l’arte in genere, che interpretano la realtà, ma certamente non la originano (tuttavia Enzo viene arrestato, forse con l’accusa di complicità). Enzo, scrivendo, ha immaginato i fatti, ma ha suggerito anche un lieto fine: che la donna si dissoci dai suoi compagni e liberi il prigioniero. Ci si chiede allora se l’immaginazione non avrebbe potuto impedire che i fatti accadessero, se fosse andata al potere, come recita un celebre slogan del Sessantotto.
Dopo aver reso omaggio alla tomba, la famiglia e gli amici di Chiara sono riuniti attorno ad un tavolo per mangiare insieme. Si alza un amico del padre (Gianni Schicchi), e comincia il discorso in onore del papà di Antonio e di Chiara che «credeva molto nelle immense possibilità dell’uomo...».
Il discorso viene interrotto proprio all’inizio di quest’ inno all’uomo e alle sue potenzialità, un richiamo vago al primo stasimo sofocleo e come quest’ultimo rinunciatario rispetto alla predominanza della morte, il cui pensiero viene poi esorcizzato con l’intonazione da parte di tutti della canzone partigiana ‘fischia il vento e infuria la bufera’. Chiara non canta, ma resta a guardare riflettendo. L’episodio è congegnato in maniera che su Chiara paia gravare l’eredità di famiglia, della lotta iniziata dal padre, una responsabilità silenziosa e ostinata ma concreta, mentre il fratello, che se ne sta nell'inerzia su un prato, genericamente si dichiara a favore dei brigatisti, 'migliori di lui' - afferma. Chiara si sente erede e portatrice di quella bandiera rossa che chiude la canzone dei partigiani, per la quale il padre fu disposto a mettere in pericolo la propria vita e che ne garantisce l’eroicità nel ricordo. Senonché è proprio nel segno del padre che si apre la più drammatica delle contraddizioni nella coscienza di Chiara/Antigone.
Osservando il prigioniero nella sua debole umanità, inconsciamente o meno Chiara istituisce un legame emotivo tra il prigioniero e suo padre, che è stato oppositore e forse prigioniero di un regime totalitario. Il Potere ha mille volti, ma sempre gli stessi meccanismi. E così, leggendo in solitudine le lettere dei condannati a morte della Resistenza, avverte l’incoercibile analogia tra le loro ultime parole e le parole di Moro alla moglie nelle missive di cui lei si fa portatrice, e che di nascosto legge prima di consegnare. Tutto sembra allora rovesciarsi: nella storia collettiva e individuale si mostraThe Dark Side of the Moon, come dice la celebre canzone dei Pink Floyd che funge da colonna sonora.
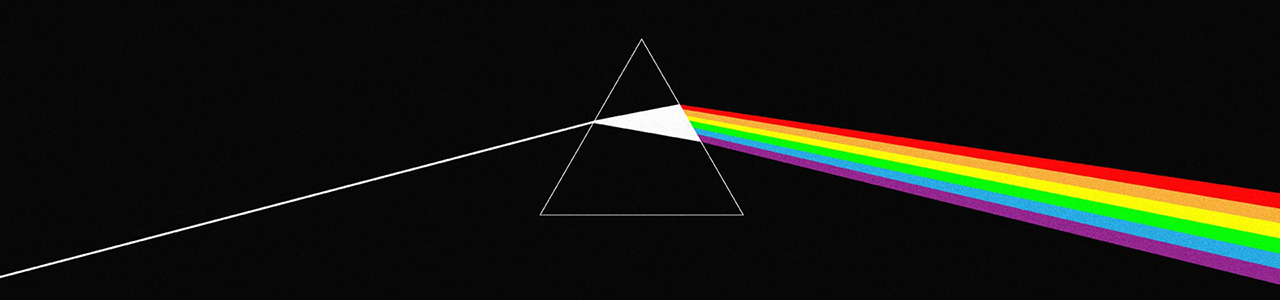
In uno degli interrogatori a Moro, un compagno (Mariano, interpretato da Luigi Lo Cascio, controfigura di Mario Moretti) discute con lui della morte. Moro ammette di aver paura di morire (l’ha avuta anche Cristo sul Getsemani, dice), il brigatista invece alla stessa domanda risponde: «Ogni uomo deve morire, ma non tutte le morti hanno lo stesso significato. Io credo che la nostra superiorità consista in questo: noi siamo disposti a morire per le nostre idee». Una battuta che amplifica lo scambio di battute tra Antigone e Creonte in Sofocle, dove la prima esplicitamente dichiara di non aver affatto paura di morire (‘mi hai preso; cos’altro vuoi farmi che uccidermi?’, v. 497), consolata dalla gloria che le deriverà dall’azione che ha compiuto (meglio morire che una vita nella vergogna per non aver almeno tentato di seppellire Polinice: cfr. vv. 466-468). Ma il colloquio riprende direttamente anche l’Affaire Moro di Sciascia: «Non credo abbia avuto paura della morte. Forse di quella morte: ma era ancora paura della vita».
Chiara sta ascoltando, guarda dallo spioncino, poi si ritira impaurita: come per aver infine compreso che non vi sono ragioni ideologiche o politiche che giustifichino il disprezzo della vita umana. Creonte ed Antigone agiscono sulla base di due diversi fondamentalismi, complementari, non opposti, ambedue strumentalizzati dall’ideologia. All’individuo non resta, forse, che uno spazio di ribellione, incontrollabile dall’esterno, la maglia che si strappa alla trama tessuta dai poteri: il sogno, la fantasia.
La ribellione di Chiara/Antigone, la sua resistenza, si esercita infatti nel sogno: lì le magnifiche potenzialità dell’uomo trovano la loro più assoluta e pura realizzazione, non si piegano a ragioni altre, sconfiggono persino la morte, si dispiegano libere. La vera ribellione di Antigone ha la forza del sogno. Anche se questo confina con la follia.
E in questa narrazione del caso Moro, risuona ancora una domanda di Leonardo Sciascia:
Si può dunque dedurre, da questo procedere che appare scriteriato, che l’essenza e il destino delle Brigate rosse stiano davvero nella sfera – a dirla banalmente – del «pazzesco» o - meno banalmente, più sottilmente – nella sfera di un estetismo in cui il morire per la rivoluzione è diventato un morire con la rivoluzione?

Sulla tragedia di Aldo Moro vedi anche qui. Altra bibliografia su questo argomento nel mio libro Antigone ai tempi del terrorismo. Letteratura,teatro, cinema Lecce, Pensa Multimedia 2016. Su L'affaire Moro come testo letterario e sulla letteratura restano importanti le pagine di Marco Belpoliti (L'affaire Moro. Anatomia di un testo, in L'uomo solo. l''affaire Moro' di Leonardo Sciascia, a cura di V. Vecellio, 2002).
Nelle foto: scene da 'Todo modo' di Elio Petri (1976), da 'Buongiorno,notte' di Marco Bellocchio (2003), dall' episodio 'Antigone rinviata' del film collettivo 'Germania in autunno' (1977). Foto dall'agguato in via Fani il 16 marzo del 1978 e dal rinvenimento del corpo di Moro in via Caetani. Un ritratto di Aldo Moro, e Aldo Moro con Francesco Cossiga.
